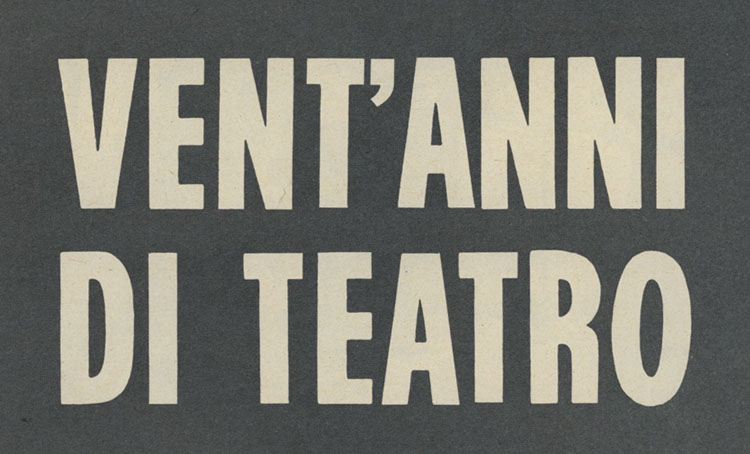Luchino Visconti rievoca per la prima volta la propria esperienza teatrale. «Se oggi il pubblico viene finalmente a teatro, vuol dire che vent’anni di sforzi da noi compiuti sono serviti a qualcosa», scrive Visconti in questa memoria, che inizia con la regia dei Parenti terribili del 1945 e conclude col recente successo del Giardino dei ciliegi.
Una sera di metà gennaio, a Roma, entrai al teatro Valle per salutare i miei attori. Era quasi mezzanotte, e attraverso l’altoparlante dei camerini sentii Rina Morelli che diceva l’ultima battuta di Liubòv Andrèievna: «Mi sembra di non aver mai visto prima d’ora i muri e i soffitti di questa casa…».
Anche quella sera, a due mesi e mezzo dalla prima rappresentazione, Il giardino dei ciliegi aveva fatto un «tutto esaurito». In sala c’erano moltissimi giovani. E oltre alla solita quota di abbonati alla stagione del nuovo Stabile c’era evidentemente un pubblico insolito per il teatro di prosa. Più che al Valle, sembrava di essere in una sala cinematografica di seconda visione, strapiena.
Sulla scena, i personaggi scomparivano a uno a uno, finché rimase solo il vecchio Firs e il sipario si chiuse: applausi interminabili come a un debutto, ma forse meno accondiscendenti e certo più spontanei di quelli che di solito vengono tributati dal pubblico delle «prime». Contai più di quindici chiamate.
Ero soddisfatto come autore della messinscena, ma soprattutto ero divertito come vecchio osservatore di fatti teatrali. Eravamo ormai alla fine del periodo concessoci dal programma dello Stabile e il botteghino era ancora costretto, ogni sera, a respingere richieste di biglietti. Molta gente che desiderava vedere lo spettacolo, a Roma, non è riuscita a vederlo.
Con un totale di settantasette repliche e oltre settantamila spettatori paganti, Il giardino ha così smentito la sua assurda leggenda. In teatro si creano spesso dei pregiudizi. In passato, a proposito di Cechov, si sentiva sempre dire: Zio Vania, Le tre sorelle e Il gabbiano sì, ma Il giardino no. Da noi, l’ultima opera teatrale scritta da Cechov non aveva mai fatto molti soldi, e i teatranti la consideravano con una sorta di superstiziosa perplessità. Io stesso avevo avuto occasione di assistere in passato ad almeno tre edizioni di questo spettacolo e sembrava proprio vero: il pubblico non riusciva a sopportare fino in fondo un testo che veniva invariabilmente messo in scena con un ritmo dilatato e smorzato, tenuto sui mezzitoni, sempre interpretato con eccessiva malinconia e con dispendio d’interminabili silenzi.
La colpa, è chiaro, non era del testo. Difatti, è bastato uscire dall’impostazione tradizionale e anche Il giardino dei ciliegi ha raggiunto un successo che a Roma equivale, credo, a un record in assoluto.
Non c’era bisogno d’inventare nulla, semplicemente bastava tener conto di quelle che erano, già nel 1903, le intenzioni dell’autore. Per Cechov, questo suo ultimo lavoro teatrale era, più che un dramma, una commedia. Prima di morire, anzi, ebbe a questo proposito una vivace polemica con Stanislawski che ne aveva dato, al Teatro d’Arte di Mosca, una versione troppo cupa e drammatica. Ma dopo di allora aveva definitivamente vinto Stanislawski, la cui messinscena era rimasta l’unico esempio da seguire.
Sono contento, adesso, di aver dimostrato con il mio spettacolo che aveva ragione Cechov. Il giardino dei ciliegi che nell’ottobre scorso ha aperto la stagione dello Stabile di Roma non è piaciuto incondizionatamente alla critica, però è certamente piaciuto al pubblico, anche a un pubblico che non aveva nessuna dimestichezza con il teatro. Alla fine, lo spettacolo è stato smontato solo per far posto al Mercante di Venezia curato da Ettore Giannini. Senza questa improrogabile scadenza avrebbe potuto tenere il cartellone per molte settimane ancora.
Poche speranze finché una poltrona costa 3000 lire
C’è da chiedersi se questo spettacolo, in un altro momento e in altre circostanze, avrebbe ottenuto lo stesso successo. Non lo so. Da qualche tempo si sente ripetere che anche gli italiani hanno finalmente scoperto il teatro. Si parla perfino di un boom teatrale, e i fatti sembrano dimostrarlo. La stagione è insolitamente fitta di buoni e ottimi risultati, ma io non sono completamente d’accordo con quelli che ne identificano le cause con un’evoluzione culturale del pubblico. Io ho l’impressione che il fenomeno sia legato a cause diverse, perfino contraddittorie, e che, alla base di tutto, dipenda da semplici ragioni di mercato.
Per la prima volta il teatro italiano cerca di fare una politica dei prezzi e cerca di arrivare in zone di mercato mai sfruttate prima. Insomma, si comincia a offrire teatro a prezzi popolari, qualche volta popolarissimi, e immediatamente si vede il risultato. In una città come Roma, dove c’è un pubblico proverbialmente distratto, lo Stabile ha raccolto, alla sua prima stagione, oltre sedicimila abbonamenti. Mi sembra una cifra enorme.
Così si sta avverando quello che alcuni di noi, inascoltati, predicavamo già vent’anni fa. Non si poteva sperare di ottenere risultati ampi, né di montare spettacoli con un certo margine di sicurezza, finché una poltrona costava tremila lire. In passato, però, nessuno era mai stato in grado di fare un lungo esperimento in tal senso perché l’incomprensione dei proprietari delle sale era totale: noi si lavorava come piazzisti del teatro, a una certa percentuale, senza avere mai la possibilità di intervenire sui sistemi di vendita e senza mai ottenere una riforma dei prezzi.
Qualcuno oggi sostiene che la politica adottata da Vito Pandolfi è pericolosa, che a Roma si vende il teatro sottocosto e che questo lavoro di promotion su un pubblico popolare è un lusso che solo un teatro sovvenzionato può permettersi. Si può rispondere che il «teatro per molti», come lo chiama Giannini, in Italia è una novità, ha bisogno di propaganda e di lancio. Il teatro è una merce culturale, ma è sempre una merce, e come tale dev’essere venduta. Solo così si può pensare di attirare a uno spettacolo un pubblico che abitualmente non ci pensa neanche.
Se la gente, finalmente, viene a teatro, può anche darsi che vent’anni di sforzi per dare una certa dignità alla nostra scena siano serviti a qualcosa. I risultati di un lavoro culturale non possono mai essere immediati. E solo oggi, da noi, il teatro comincia forse a diventare, per un pubblico più largo, una necessità come quella che spinge la gente a comprare giornali per avere notizie.
Cos’è stato il teatro, in Italia, finora? Uno svago da prendere in posizione digestiva, un dopocena, riservato per lo più a poche migliaia di clienti di un certo ceto, in un paese dove quasi cinquanta milioni di persone non ne hanno mai saputo nulla o quasi. Adesso mi pare che questo genere di spettacolo si stia smitizzando un poco. Ma non è tanto il pubblico che lo sta scoprendo. Piuttosto è il teatro che sta scoprendo il suo vero pubblico.
Luchino Visconti
Roma, 24 marzo 1966
(segue)